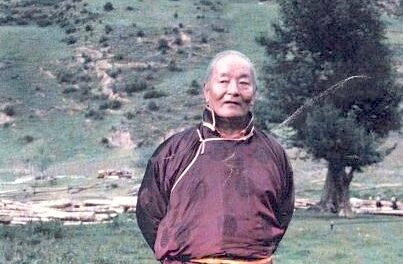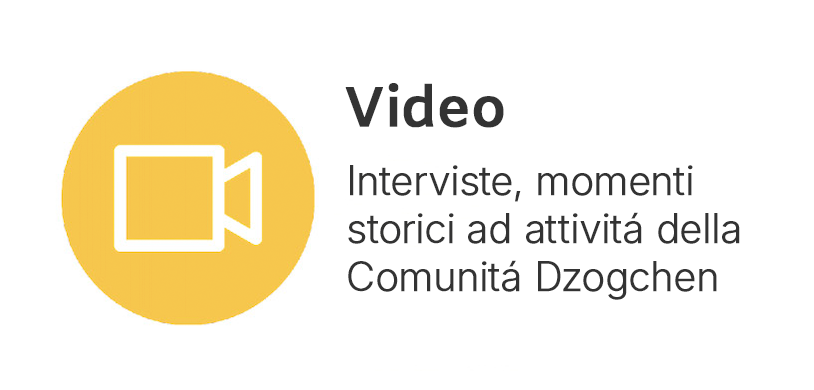Raimondo Bultrini
Per trentatre anni ho voluto raccontare le mie esperienze di viaggio con Chögyal Namkhai Norbu agli altri suoi studenti. Avevo già scritto un piccolo libro in italian (In Tibet, Shang Shung Editions) subito dopo essere tornato in Italia nell’inverno del 1988, grazie all’editore della rivista di Merigar che a quel tempo era Cesare Spada. Il libro, che contiene i momenti salienti di questo viaggio, era troppo corto e troppo fresco per poter dare la profondità e il fascino dei dettagli di una esperienza unica e ora irripetibile.
Negli anni seguenti ho trascritto – dando loro la forma di un resoconto di viaggio – gli appunti del mio diario dal giorno in cui Rinpoche arrivò a Beijing a metà febbraio del 1988, invitato a dare una serie di conferenze per l’Istituto Nazionale delle Minoranze che ci avrebbe portato dalla capitale cinese a Chengdu e da lì al Tibet orientale fino a Lhasa. Ho continuato a trascrivere i miei appunti e impressioni per tutto il turbolento e straordinario pellegrinaggio dalla capitale tibetano verso il monte Kailash, in compagnia di altri settanta studenti, tutti più o meno collegati a diverse comunità Dzogchen in giro per il mondo.

Raimondo davanti alla casa di Changchub dorje a Khamdogar, dove il corpo del maestro era ancora conservato in una cassa sotto sale. Dopo le cerimonie con Rimpoche inizierà il processo di distribuzione delle reliquie nei diversi stupa del villaggio
Invecchiato e con la memoria che comincia ad appannarsi la trascrizione del diaro è, credo, un documento importante di per sè e, spero, per gli studenti del Maestro, anche se la mia intenzione quando l’ho scritto era quello di rivolgermi a un vasto pubblico. Così molte cose saranno scontate per chi di voi ne leggerà alcuni passaggi.
Oggigiorno la narrazione romanzata della storia mi sembra che manchi di profondità e spero di essere in grado di usarla come base e di ripulirla degli errori grossolani di trascrizione dei nomi, di fatti e circostanze imprecisi. Ciò nonostante non credo che certe carenze distorcano completamente il significato di quello che ho visto e sentito, spesso dalla voce del Maestro che per molti mesi è stato l’unico interlocutore e interprete di quello che ci accadeva intorno, visto che le uniche parole in tibetano che conoscevamo erano quelle dei mantra, imparate a memoria ma che non sempre collegavamo al loro significato.
Questa prima parte che offro ai lettori del The Mirror con l’umiltà di uno studente culturalmente inadeguato per accompagnare un maestro della conoscenza qual era Rinpoche, non riguarda per ora il viaggio vero e proprio. Rileggendo il mio diario ho trovato la trascrizione di una conferenza che il Maestro tenne a Chengdu a giovani studenti e professori dell’Istituto delle Minoranze con cui vorrei introdurre il senso della “missione” del Professor Norbu in quei mesi ricchi di eventi a cui sono stato fortunato di partecipare.
Molte delle cose scritte saranno note ai lettori e a chiunque abbia letto il mio libro o sentito le parole di Rinpoche. Qui però erano indirizzate a giovani studiosi tibetani e cinesi e ai loro docenti allo scopo di approfondire la storia antica in chiave moderna. Solo andando alla radice – ho sintetizzato il lungo discorso da me trascritto quasi per intero e che potete leggere di seguito – è possibile capire la necessità di preservare la cultura tibetana. Dovete però liberarvi dall’idea di trovare delle risposte, prima ancora di studiare senza pregiudizi, così come ogni ricercatore dovrebbe fare. Un suggerimento pratico è quello di studiare l’inglese, una lingua che dà accesso ad altri tipi di conscenze che oggigiorno sono necessarie per comprendere il mondo contemporaneo e contrastare la tendenza di riscrivere la storia e trasformare il Tibet in un museo.
Ricerca della cultura tibetana
Nel 1988 durante il suo viaggio in Asia Chögyal Namkhai Norbu fu invitato a dare una serie di conferenze in diversi posti della Cina iniziando da Chengdu, poi nel Tibet orientale per finire a Lhasa. Quello che segue è la traduzione della trascrizione di una conferenza che il Maestro ha dato a Chengdu, nella provincia del Sichuan in Cina, a un pubblico di giovani e docenti dell’Istituto delle Minoranze. Nella sua conferenza parlò del senso della “missione” da lui portata avanti in quei mesi così pieni di eventi.
Cari professori e studenti,
sono molto contento di essere di nuovo qui con voi dopo tanti anni. Quando ero giovane, se ben ricordo tra il 1953 e il 1954, venni infatti per la prima volta in questa scuola ad insegnare il tibetano e al tempo stesso per apprendere il cinese. Qualcuno lo ricorderà perché vedo tra voi alcuni colleghi conosciuti all’epoca.
Sono passati tanti di quegli anni che gli studenti di allora sono diventati docenti, funzionari, professionisti. Sono contento di essere qui non soltanto per la nostalgia di quegli anni ma anche perché ho notato da parte di tutti, sia professori che allievi, un profondo interesse per la cultura tibetana e per ciò che in Occidente ho avuto personalmente modo di apprendere in tutti questi anni di ricerca.
Sappiamo che la cultura tibetana è così antica da rappresentare di per sé un valore, non solo per il nostro paese e il nostro popolo ma per il mondo intero. A livello internazionale tutti oggi riconoscono infatti questo valore come contributo per accrescere la conoscenza e la saggezza. La saggezza spirituale in primo luogo ma anche la consapevolezza civile.
Abbiamo attraversato momenti difficili. Io, per esempio, di ti trent’anni da sono stato qui. Poi, per varie circostanze, per varie circostanze, come tutti sanno, sono uscito dal Tibet e ho raggiunto l’India. Non avevo la minima idea di andarmene definitivamente e di lasciare il mio paese ma la nostra vita dipende anche dalle circostanze.
So che c’è un giudizio negativo nei confronti di quanti sono andati via. Per quanto mi riguarda, ripeto, la verità dei fatti è ben diversa. Ciò che è avvenuto non era nelle mie intenzioni, non immaginavo nemmeno che avrei studiato all’estero e che avrei contribuito così alla salvaguardia della mia cultura. Ma, come si dice in tibetano, “la causa negativa porta anche la fortuna”. Siccome in quell’anno, il 1959, lo stesso governo tibetano aveva abbandonato il paese, non potevo più tornare indietro. Decisi quindi di lasciare anche l’India e cercare un luogo dover poter studiare e fare qualcosa di utile.

Chögyal Namkhai Norbu (a destra) che cammina per Chengdu con sua sorella, Sonam Palmo, nel 1988. © 2021 Collezione Namkhai / MACO
Fu così che raggiunsi l’Italia. Lì c’era un famoso studioso, Giuseppe Tucci, uno dei primi che si fosse interessato alla cultura tibetana divulgandola nel mondo occidentale. Mi invitò per una collaborazione di due anni, io accettai e partii per il nuovo paese.
Per mia fortuna quel professore possedeva, nell’Istituto per il Medio ed Estremo Oriente da lui fondato, una tra le più grandi collezioni di testi tibetani al mondo, forse la più grande. Così ebbi modo di leggere, studiare molto e collaborare con il professor Tucci. Naturalmente nei primi anni non leggevo altro che il tibetano. Non conoscevo l’italiano e quel poco di inglese imparato in India non mi serviva, perché in Italia ben pochi parlavano questa lingua.
Come ben sapete noi tibetani incontriamo parecchie difficoltà nello studio della altre lingue. Prima di tutto la struttura stessa della nostra lingua è completamente diversa da quello di ogni altra. Inoltre in Tibet non c’era nessuna opportunità di studiare le lingue straniere.
A tutt’oggi, a tanta distanza di tempo, non esiste per esempio un dizionario tibetano-italiano, bisogna usarne uno dall’inglese.
Così, con un certo sacrificio, ho imparato l’italiano. Certamente lo studio di una lingua straniera non può limitarsi all’apprendimento di un linguaggio ma serve a comprendere il modo di vivere del paese, la sua cultura, le sue conoscenze e abitudini, completamente diverse. Magari che vive sempre in uno stesso paese non si rende conto di tutto questo ma conoscere altre lingue è importantissimo e perciò oggi tutti lo studiano, per sviluppare la comunicazione, approfondire la conoscenza della realtà.
Quindi io ho imparato molto leggendo da un lato numerosi libri tibetani, dall’altro vedendo il mondo dell’Occidente, il modo di pensare, di studiare, di fare la ricerca. E così per la prima cosa mi sono reso conto dell’importanza della cultura. Prima infatti non avevo le idee molto chiare su questo. Pensavo che per un paese fosse fondamentale lo sviluppo economia, la forza militare e l’organizzazione di governo ma poi osservando meglio la vita e lo sviluppo dei paesi occidentali ho capito che, seppure indispensabili, lo sviluppo economico e militare non avevano per l’individuo la stessa importanza della cultura.
Ho visto che in Occidente la scuola elementare è obbligatoria per tutti i cittadini e si può dire che al giorno d’oggi non c’è quasi più nessuno che non abbia frequentato le elementari. In Italia, per esempio, non soltanto le elementari ma anche le scuole medie sono obbligatorie. Questo vuol dire che in Occidente tutti sanno almeno leggere, scrivere e di conseguenza hanno maggiori capacità di ragionamento, di comprensione intellettuale.
Ecco, questa dell’istruzione è la base stessa dello sviluppo della cultura. E poi, andando più a fondo, mi sono reso conto che il valore di ogni cultura è legato alla storia di un paese, di un popolo, alle sue origini. Su questo ho riflettuto molto.
Io ho vissuto ormai più di metà della mia vita in Occidente ed è probabile che continuerò a viverci ancora. Ma sono nato e ho studiato in Tibet, così ho sentimenti e legami molto vivi e forti con la cultura del mio paese.
Se rischiasse di andare perduta non se sarei soltanto dispiaciuto ma farei qualunque cosa in mio potere per salvarla. E questo non soltanto io ma di sicuro tutti i tibetani, ovunque si trovino, in India, in Tibet, in Cina. Ovunque tutti nutrono questo sentimento di riconoscenza.
Però certamente nutrire un sentimento non basta. In qualche modo bisogna agire in pratica, fare qualcosa per divulgare e diffondere questa conoscenza ma soprattutto comprenderne bene il valore. Così ho capito che dovevo risalire alle origini della cultura tibetana e scoprire il valore reale. Dopo due anni di lavoro con il professor Tucci, l’Università Orientale di Napoli mi offriva una cattedra di letteratura tibetana. Così, mentre svolgevo il mio nuovo lavoro cercavo di seguire anche l’attività didattica e le conferenze degli altri professori. Questo confronto mi è servito molto e ho riflettuto sul fatto che la maggior parte dei testi tibetani, almeno quelli più accreditati, sono buddhisti. Ma
noi sappiamo che prima dell’avvento del buddhismo in Tibet esisteva il Bönpo, la cultura delle origini, e che dopo l’ VIII secolo d.C. questa è stata trascurata. È nell’ordine naturale delle cose, quando in un paese sorge qualcosa di nuovo, tutto ciò che esisteva prima viene considerato privo di valore. Succede spesso. In Tibet è stato così. Per questo motivo nello studio della nostra storia si risale fino a Songtsen Gampo e non oltre. Le origini della cultura tibetana vengono fatte risalire di conseguenza all’India e anche in parte alla Cina per scienze come la medicina e l’astrologia, ignorando totalmente tutto ciò che c’era in Tibet prima di Songtsen Gampo.

A sinistra Keng Leck, al centro Ayang Tulku, davanti al centro Alex Siedlecki. Foto per gentile concessione di Keng Leck.
Ma vediamo le cose con ordine, a cominciare dall’origine del popolo tibetano. I libri di storia di cui stiamo parlando dicono che Songtsen Gampo è una emanazione di Avalokiteśvara. Poiché Avalokiteśvara è un bodhisattva, mosso quindi dalla compassione, sarebbe stato lui a portare la luce in Tibet, un paese buio e senza cultura, senza spiritualità, insomma un luogo abitato da selvaggi.
Alcuni testi narrano addirittura che, quando Buddha Sakyamuni viveva in India, più di 2.500 anni or sono, in Tibet non c’erano ancora esseri umani. Un bodhisattva, probabilmente lo stesso Avalokiteśvara, stando di fronte a Buddha vide una luce espandersi dalla sua fronte in direzione del Paese delle Nevi. Al bodhisattva che gli chiedeva spiegazioni di quella visione il Buddha rispose: “È un segno dell’avvenire, Una tua emanazione genererà la popolazione del Tibet che successivamente seguirà il mio insegnamento e si diffonderà la luce nel paese.”
Fu così che, secondo questi testi, Songtsen Gampo, come emanazione di Avalokiteśvara, invitò i maestri buddhisti dall’India e dalla Cina, portando finalmente in Tibet una civiltà perfetta. E questo è anche il motivo della grande devozione che i tibetani devono nutrire per il re–bodhisattva e i suoi discepoli.
Ma la verità non è proprio quella descritta dai libri. Lasciamo a chi crede in queste cose la questione se Songtsen Gampo fosse o meno una emanazione di Avalokiteśvara ma dal punto vista storico non è stato cero questo il motivo principale cha ha spinto Songtsen Gampo a introdurre le conoscenze indiane e cinesi in Tibet.
Prima di lui ci sono stati almeno una trentina di re del Tibet, a cominciare dal primo, Odepujal (Myaktri Tsampo) che, vissuto più o meno al tempo di Buddha Sakyamuni, non regnò certamente su terrori privi di esseri umani e dal tempo di quel re fino a Songtsen Gampo tutti i sovrani e il popolo hanno seguito e praticato la religione Bön. Quindi non era nemmeno un paese buio come dicono, ma c’era una cultura, una conoscenza spirituale.
Inoltre, anteriormente all tempo di Odepujal, esisteva nei territori dell’odierno Tibet occidentale un regno famoso chiamato Shang Shung. Era questo il regno originario del popolo tibetano, con la capitale vicino al monte Kailash, diviso in tre aree, Shang Shung interno, centrale ed esterno. Lo Shang Shung centrale corrispondeva alla regione del Kailash, dove ha sempre avuto sede la capitale, quello esterno agli attuali Tibet centrale e orientale mentre lo Shang Shung interno comprendeva vasti territori intorno alla catena del Karakorum, comprese alcune regioni dell’ex Unione Sovietica, della’Afghanistan, del Pakistan. Un impero, dunque, che fu vasto e potente.
Quanto al Tibet, ai suoi inizi era un piccolo regno tributario dello Shang Shung. In tempi nei quali i metodi di governo non erano quelli di oggi, una simile condizione comportava al massimo di dover fare riferimento a quella lontana autorità che inviava di tanto in tanto dei suoi rappresentanti ed esigeva il pagamento di qualche tributo.
Lo Shang Shung, storicamente, ovvero risalendo a più di 3.890 anni fa, era anche la patria del Bön. Il maestro delle origini di questa religione si chiamava Tonpa Shenrap e il suo principale sostenitore era un potente sovrano della Shang Shung, re Triwer (*).
La storia tibetana comincia a quei tempi. Vi sono infatti testimonianze scritte degli eventi e dall’epoca sappiamo che sul trono dello Shang Shung si sono avvicendati 18 famosi re. Poi è nato il Tibet che, seppure con un nuovo nome e altri re, era pur sempre dipendente dallo Shang Shung, non solo perché le origini culturali erano le stesse, cioè il Bön.
Dovunque ci fosse il Bön c’era in qualche modo anche il potere dello Shang Shung. Fu così che, dopo sette dinastie tibetane, alcuni re iniziarono a voler porre sotto controllo il potere dei sacerdoti Bönpo.
In particolare l’ottavo re del Tibet, Drigum (*), scese in campo contro questi sacerdoti uccidendone molti e distruggendo i monasteri ma il paese, tutto il popolo era radicato nell’antica religione, fedele ai suoi rappresentanti. Il re fu assassinato da un ministro prima che avesse avuto il tempo di portare a termine il suo progetto. Alla fine le cose tornarono come prima.

Da sinistra: Rinpoche, Alex Siedlecki, Cheh Goh, Keng Leck e Adi dalla Grecia. © 2021 Namkhai Collection/MACO
Altri re tentarono senza successo di sradicare il Bön, finché non si giunse ai tempi del famoso re Songtsen Gampo. Era un re di grande intelligenza. Stabilì subito una serie di alleanze dinastiche chiedendo ed ottenendo come mogli prima una principessa dello Shang Shung, poi una del Nepal – un regno, all’epoca, prezioso ponte di comunicazione con l’India – e infine una cinese.
Il disegno di Songtsen Gampo non era certamente solo quello di prendere delle mogli o di allacciare relazioni diplomatiche ma quello di importare dai loro paesi d’origine le conoscenze che avrebbero permesso di creare la nuova cultura tibetana.
Nella versione buddhista della storia, che è poi quella ufficiale, prima di Songtsen Gampo in Tibet non esisteva la scrittura. Così un giorno il re mandò un suo ministro in India per imparare il sanscrito e al suo ritorno cambiarono sia il sistema di scrittura che la grammatica. Da qui la considerazione di Songtsen Gampo come salvatore del Tibet e portare di civiltà ma la verità non è esattamente questa. Un sistema di scrittura esisteva ed era già in uso da tempo in tutto lo Shang Shung, Tibet compreso, ma il re volle creare un alfabeto che appartenesse interamente al suo regno Oggi si usa in Tibet una scrittura in stampatello chiamata Uchen mentre la scrittura antica derivante dallo Shang Shung, viene utilizzata come corsivo.
Ecco quindi chiarito che, sebbene esistesse già una scrittura, i buddhisti hanno preferito lasciare intendere che fosse stato proprio un re della loro religione a inventarne una e a donarla ai tibetani. In questo modo Songtsen Gampo è comunque riuscito nei suoi scopi. Ha portato il buddhismo nel paese invitando maestri dalla Cina e dall’India, creando così una nuova cultura che prendeva il posto dell’antica.
Questa scelta ha contribuito certamente in maniera determinante a sviluppare e completare la cultura tibetana, ma avendo attribuito tutti i meriti all’India e alla Cina si è commeso l’errore di ignorare il valore della tradizionale originaria Bön.
Fu comunque proprio Songtsen Gampo a tenere sotto controllo per primo il potere dei sacerdoti Bönpo mentre più tardi uno dei suoi successori, Trison Detseng (*), invitò il grande maestro Padmasambhava e il dotto Sataraskita, per costruire il tempo di Samie, eliminando gran parte della tradizione Bön dell’epoca. Trison era riuscito positivamente in questa sua impresa perché non aveva soltanto distrutto, ma sostituito gradualmente, costruito e sviluppato la nuova cultura buddhista.
L’epoca di Sogtsen Gampo fu infine segnata da un altro importante evento storico, la fine dello Shang Shung. Venne infatti annesso al Tibet dopo che Songtsen Gampo ne ebbe ucciso il re. E dell’ex potente impero non restò più nemmeno il nome.
Questa è la storia che spiega perché Sogtsen Gampo ha portato il buddhismo in Tibet. Non perché non esistesse già una religione o perché il paese era al buio, abitato da selvaggi. C’era piuttosto un preciso motivo politico.
Penso che sia molto importante per tutti noi, interessati alla cultura tibetana comprendere bene tutto questo. Perché una cultura come la nostra, che può far risalire le sue origini a più di 3.890 anni fa, ha storicamente un valore non inferiore a quello di culture come l’indiana o la cinese. Non può essere ignorata la storia di una nazione esistita sulla Terra per così lungo tempo poiché rappresenta un tesoro mondiale.
Se non comprendiamo tutto questo, la gente continuerà a prendere in considerazione solo gli aspetti folcloristici delle nazionalità di minoranza e dei ceppi etnici, senza considerare il valore della loro cultura. Non può essere così. Una conoscenza profonda, esistita 4.000 mila anni fa, che ancora vive e viene trasmessa è una cosa grandiosa, importante, non può andare persa.
Esistono molte culture sulla terra e certamente tutte hanno il loro valore particolare e vanno salvaguardate. Ma quante di queste culture custodiscono in sé valori universali?
Prendiamo ad esempio, in Tibet, le teorie sull’origine dell’uomo. Molti studiosi tibetani quando parlano delle origini sostengono che, secondo l’antico Bön, tutto sarebbe sorto dall’uovo cosmico. Altri studiosi ridono di questa teoria, la ritengono una sciocchezza, altri ancora sostengono che il principio dell’uovo cosmico non è originario del Bön ma preso a prestito più tardi dell’induismo e dello shivaismo.
Se è uno studio a sostenere certe tesi, tutti sono subito pronti a credergli. Perché? Perché si pensa che il Tibet sia un paesino che può avere, sì, una sua cultura, ma non certo la storia e il valore delle conoscenze acquisite da altre nazioni più antiche e importanti. Fosse quindi anche la più originale tra le tradizioni dalla cultura tibetana, questi studiosi si domandano sempre, da dove viene? Dalla Cina o dall’India?
Torniamo all’esempio di prima. A pensarci bene se anche fosse vero che la teoria dell’uovo cosmico proviene dallo shivaismo, c’è sempre da domandarsi l’origine dello shivaismo stesso, che nei testi sacri di questa religione si colloca sul monte Kailash. Ma dov’è il monte Kailash? È in Tibet, non vero in India. Più precisamente è il cuore dell’antico regno dello Shang Shung, patria del Bön. Ecco quindi che lo shivaismo, e tutte le sue teorie, vengono dal Bön e non viceversa.

ChNN con Cheh Goh e Keng Leck, in partenza da Chengdu per Derge, 1988. Foto per gentile concessione di Keng Leck.
Naturalmente questo è solo un esempio. Ma basta rifletterci e se ne troveranno molti altri di casi analoghi. Se non si ragiona non si dà alcuna importanza a questi aspetti, legati soltanto alla conoscenza di nozioni generali, ma soprattutto ai valori dell’esistenza. Prendiamo un altro esempio. Si dice che, come esseri umani, noi abbiamo un livello fisico, ma anche uno mentale. Quello mentale è più profondo, più difficile da comprendere.
Su questo aspetto, nella tradizione del Bön è esistito anche l’insegnamento Dzogchen, un termine usato anticamente per definire il Bön della mente pura. È un insegnamento così importante che anche nel buddhismo, nel tnatrismo, la finalità della conoscenza è considerata Dzogchen. Se 3.000 anni fa, dunque, già esisteva un interesse così profondo verso la natura della mente umana. Paragonabile a una filosofia, si può comprendere meglio il grande valore di questa cultura.
Ma la cultura di un paese è legata al popolo. Se il popolo non l’applica e non vive di questa cultura, se esiste soltanto come conoscenza intellettuale, si può intuire che, più o meno, è una cultura morta. Dico questo a voi studenti perché siete venuti qui da diverse zone del Tibet centrale e orientale, dallo Qinqai, dal Kansu, dallo Yunnan, proprio per approfondire questi aspetti della nostra cultura che spero svilupperete con lo studio, la ricerca. È molto importante fare questa ricerca con la mente libera. Sapere che cosa vuol dire questo? Che un ricercatore non deve appartenere necessariamente o essere contrario a una religione, oppure ritenersi ateo, materialista. Se qualcuno è condizionato da questi limiti non sta ricercando seriamente. Fare ricerca non vuol dire limitare se stessi, o cercare di approfondire gli aspetti che giustificano una sua ideologia già prefissata.
Mi è capitato di vedere, alcuni anni fa, molti libri tibetani stampati in Cina e in Tibet, in particolare testi di scuole buddhiste. Da qualche parte ha sempre trovato scritto: “È stato deciso di stampare questo libro anche se non segue i principi del materialismo…”. È come stabilire ufficialmente che tutti devono seguire il punto di vista del materialismo.
Sul livello politico non saprei che cosa dire, magari può avere una giustificazione ma questo non può essere l’approccio di chi vuole fare ricerca. Ricerca vuol dire leggere, studiare qualsiasi cosa, sia essa Bönpo, o buddhista, o rituale. Non è importante da dove viene se contribuisce a scoprire qual è la verità e nel mondo occidentale molto veri ricercatori hanno raggiunto risultati importanti applicando questo metodo, senza porsi dei limiti. Così spero facciate anche voi.
Il valore dell’uomo è quello di essere libero, es essendo libero si applica, cerca, distingue tra buono e cattivo. Chi sa fare ricerca probabilmente sa trovare anche la propria identità di individuo, finalmente.
Spero che sappiate proseguire su questo livello, studiare e approfondire. Con questo augurio ci salutiamo e spero di incontrare nuovamente tutti voi.
Foto in primo piano: Namkhai Norbu (a destra) mentre passeggia per Chengdu con sua sorella, Sonam Palmo, nel 1988. © 2021 Namkhai Collection / MACO
Questo post è disponibile anche in:
Inglese