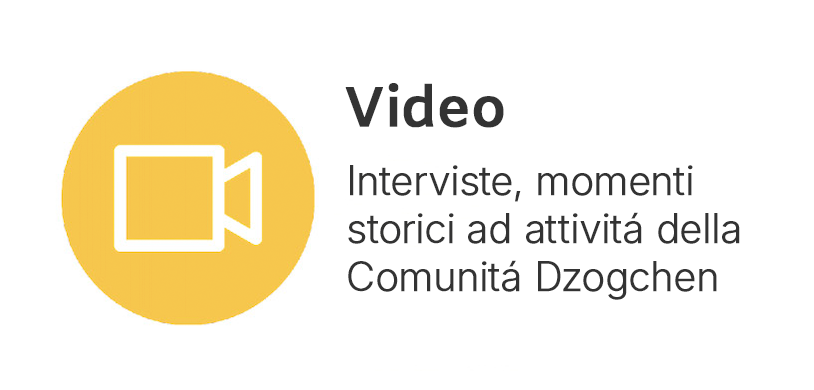Scrittore e giornalista Raimondo Bultrini racconta il suo viaggio con Chögyal Namkhai Norbu, con l’aiuto del suo diario e ricordi, attraverso la Cina e poi in Tibet avvenuto nei primi mesi del 1988
Onore ai maestri del passato
Al mio padre e mentore
Alle sorelle e fratelli del Vajra

Raimondo, nel 1988, di fronte alla casa di Changchub Dorje a Khamdogar, dove giaceva ancora il corpo del Maestro conservato sotto sale
Da unico testimone occidentale di tutti gli 8 mesi del viaggio di Choegyal Namkhai Norbu tra Cina e Tibet nel 1988, ho sempre sentito il dovere di raccontare quantomeno i passaggi che ritengo siano più significativi di quell’esperienza unica e irripetibile. È un dovere verso quanti, non solo i più giovani, conoscono poco questo importante periodo nella vita del maestro. Ogni giornata potrebbe prendere da sola lo spazio di un lungo articolo e mi perdonerete se le cause personali accumulate mi hanno impedito di dedicarmi completamente a un riassunto più dettagliato. Ma qui vorrei il più possibile condensare il senso di quel percorso che preparato in dettaglio nei mesi precedenti.
Rimpoche aveva appena concluso un tour di seminari e ritiri in varie parti dell’emisfero orientale e avrebbe interrotto per quel periodo tra Cina e Tibet i ritmi imposti dalle continue richieste di praticanti da tutto il mondo che lo invitavano ad insegnare lo dzog chen. In Cina, dove non esisteva ancora un gakyil della comunità, i suoi libri sul bon e l’antico Tibet erano già pietre miliari della storiografia tibetana. Nei mesi che ho avuto la fortuna di condividere a suo stretto contatto ho potuto osservare il passaggio del maestro dalla dimensione della cultura occidentale dell’Italia di quegli anni – con una popolazione quasi equivalente di cattolici conservatori e comunisti – a un mondo di tradizioni dove tutti seguono il buddhismo Vajrayana e in gran parte vedevano Rimpoche come fonte di benedizione ben più che di sapienza. Rimpoche ribalterà quel punto di vista in diverse occasioni parlando a nomadi, pastori e contadini, ma anche a professionisti e politici, dei metodi di autoliberazione che attraverso il guru yoga di unione con i propri maestri rende indivisibile il praticante dalla fonte della massima benedizione possibile, lo stato di contemplazione.
In ogni caso Rimpoche era consapevole di non poter deludere quanti si avvicinavano con la testa china per farsi imporre le mani dal guru identificato come intermediario della divinità stessa. “Qui è diverso. Che altro posso fare se qualcuno va dietro alle forme? Almeno posso recitare per loro un mantra” disse un giorno sorridendo quando gli chiesi perché non avesse mai adottato quel gesto in occidente. Aveva appena finito di toccare centinaia di teste, recitare altrettanti mantra e stava donando innumerevoli oggetti di protezione a quanti ne avevano fatto richiesta soffiando su di essi sillabe sacre, il maestro notò la mia attenzione curiosa e poteva leggermi nei pensieri come un libro aperto. Allora raccontò di quando molti anni prima a Torino durante un ritiro gli capitò di incontrare un occidentale che voleva essere in tutto e per tutto tibetano. “Avevo appena finito di parlare del guru yoga – raccontò – e suonammo una A prima di dedicare i nostri meriti. Alla fine un uomo si avvicina al mio posto e con rispetto mi chiese se poteva avere una benedizione. Gli dissi che l’aveva già ricevuta con la pratica dell’unione, ma lui insisteva e allora chiesi che tipo di benedizione volesse. “Non so, faccia qualcosa, mi tocchi…” Ridemmo a lungo e la scena mi tornerà in mente spesso vista l’intensità antica della relazione maestro devoto ben oltre il contatto fisico e mistico.
In gran parte Rimpoche ha indossato la stessa giacca a vento rossa e si è vestito con gli eleganti indumenti religiosi solo quando gli chiedevano di guidare cerimonie e iniziazioni rituali. C’è anche una foto con un elegante abito pesante di velluto che arrivava ai piedi sottilmente ricamato di motivi tibetani e Rimpoche disse che era la veste di antenati aristocratici che furono consiglieri di re.

Rinpoche a Galenteng mentre dà una iniziazione
Personalmente non avevo mai visto il maestro indossare gli abiti sacri sacri in occidente, e non credo lo abbia mai fatto, ma in quei mesi – oltre alla foto con la chugkpa amaranto – mi capiterà in almeno due speciali occasioni di scattargli delle foto negli abiti del rito. La prima volta trasmise con un mantello ricamato di rosso a trame dorate e una camicia gialla appartenuti allo zio Khyentse Wangchuk un’iniziazione a più di mille nomadi dell’area attorno al monastero di Galenteen. Eravamo sotto un enorme tendone bianco aperto ai lati e adattato a gompa con centinaia di uomini, donne con turchesi nei capelli e bambini sul prato gremito anche di cavalli e cavalieri, monaci addetti all’incenso del sang il cui fumo odoroso di cipresso avvolgeva ogni cosa.

i monaci a Galenteng e il rito del Sang
La seconda occasione fu il rito per consacrare gli stupa nel villaggio del suo maestro Changchub Dorje, durante il quale indossava un mantello di tonalità rossa con fasce azzurre sul quale erano stampati i saggi del lignaggio. In tutte queste occasioni la cerimonia assumeva forme esteriormente molto diverse da quelle che avevo praticato a Merigar e nei Gar occidentali. Difficile descrivere l’intensità delle emozioni scatenate credo anche nel Maestro dalla magia di quei momenti, tra sguardi attenti di volti dai tratti etnici immutati da tempo immemorabile, la musica dei lunghi corni e il cupo rimbombo dei grandi tamburi, la nuvola odorosa piacevole all’olfatto usata per la purificazione anche tra gli indiani d’America, come mi disse Rimpoche che aveva assistito tra i Navaho a riti simili al sang tibetano: “Molti mi scambiavano per uno di loro e chiedevano da quale tribù venissi”.
His expedition, which he began in China as an academic, switched between three levels when he arrived in the eastern and western highlands: that already mentioned of being venerated, that of the yogi-pilgrim in the places of his mentors and masters (including the sacred Mount Kailash in the company of a seventy students like me who came from all over the world) and finally, on a more political level, that of negotiating delicate relations with the Chinese authorities. It was in the first and second part of the trip (described briefly in a small book by Shang Shung published shortly after our return to Italy) that the core of ASIA’s projects was born and entrusted to Andrea Dell’Angelo, who returned with the Master and Giovanni Boni to the same places to start work on them.

Chögyal Namkhai Norbu e Gangkar Chökyi Senge, 1953
Nell’approccio con i funzionari che avrebbero dovuto sostenere i progetti futuri, Rinpoche fu favorito dalle cause che aveva già seminato in gioventù. A introdurlo presso governatori locali e capi del partito tibetani e cinesi furono infatti studiosi e professori delle principali università di studi tibetologici che erano stati suoi studenti o lo avevano conosciuto negli anni ’50 come rappresentante dei monasteri tibetani. Nel 1953 fu invitato dalla Gioventù comunista cinese a visitare Chengdu – che sarà una delle nostre tappe – e Chongqin, poi gli chiesero di insegnare la lingua tibetana a Menyag e per tre anni fino al 1957 fu docente alla South-western University for Minorities di Chengdu dove a sua volta studiò cinese classico e mongolo. Fu in questo periodo che Rinpoche incontrò Kangkar Rinpoche, una figura molto importante per la sua formazione anche umana, tanto che passando vicino al suo monastero Rimpoche fece acquistare a tutti noi delle coperte fabbricate per finanziare gli yogi che ne continuano il lignaggio.
The meeting that marked the turning point for Chögyal Namkhai Norbu took place in 1955 when he was still 17 and living in Chengdu. A dream took him to his master Rigdzin Changchub Dorje in Khamdogar or Nyaglagar beyond the borders of central Tibet, where we will go in early summer.
Le aperture cinesi
A curare per noi il rilascio di tutte le autorizzazioni e visti compreso il mio in quanto assistente di Rimpoche fu proprio uno di quegli studenti assidui frequentatori delle sue lezioni a Chengdu e altri centri della provincia, divenuto un importante funzionario della Regione autonomia tibetana a Pechino. Ne incontreremo molti di ex allievi a Chengdu e a Kangding, importante città a maggioranza tibetana con un rinomato centro universitario tecnologicamente avanzato. Qui l’accoglienza nell’ateneo tecnologicamente più avanzato del Sichuan fu tale che il nostro gruppo venne fatto passare tra due ali di studenti con le katà bianche tradizionali e il fiocco rosso dei “pionieri” comunisti, insegnanti e gente del posto sventolavano bandiere buddhiste (è vietato il tradizionale leone delle nevi) e quelle rosse della Cina.
I capi politici e gli amministratori, in linea con il nuovo corso più aperto e tollerante del partito, non vedevano più come un pericolo l’idea di preservare – come proponeva loro Rimpoche – l’antica cultura dei tibetani. Anche i tulku, i cosiddetti “buddha viventi” secondo la definizione cinese, erano stati in un certo modo “riabilitati” dopo gli eccessi dell’esercito e le persecuzioni della rivoluzione culturale (negli anni ‘90 una legge affidò poi la loro selezione al partito che ipotecò la scelta stessa delle reincarnazioni principali come il Dalai e il Panchen lama).
Rimpoche parlò spesso di questa antica istituzione iniziata da un maestro Kajugpa nel XIII secolo (e “copiata da tutte le altre scuole”, disse) verso la quale era piuttosto critico per l’uso troppo distorto del titolo e l’eccessivo potere materiale delle istituzioni che contano sulla fama del tulku. Anticipava quello che dirà lo stesso Dalai lama molti anni dopo: “Man mano che l’era degenerata avanza aumentano i riconoscimenti di reincarnazioni di importanti lama. Per qualche motivo politico sono stati riconosciuti un incredibile numero di persone con criteri inappropriati e discutibili, e questo ha enormemente danneggiato il Dharma”. La prova è – scrive – che la Cina ha creato delle speciali commissioni politiche per gli affari religiosi con il potere di “certificare i Buddha viventi”, come il partito chiama le presunte “reincarnazioni“. Nel 2017 sul New York Times Sua Santità usò parole ancora più chiare e inequivocabili su come impedirà ai cinesi ogni possibile stratagemma per sostituirlo: “Tutte le istituzioni religiose, tra cui il Dalai Lama, si sono sviluppate in circostanze feudali – disse – corrotte da sistemi gerarchici, e hanno cominciato a discriminare tra uomini e donne; sono giunti (perfino) a compromessi culturali con leggi simili alla Sharia e al sistema delle caste”. “Pertanto (con me), l’istituzione del Dalai Lama, con orgoglio, volontariamente, si è conclusa”.
Rimpoche aveva spiegato più volte a me e altri compagni di viaggio che la fama e il prestigio del titolo tra le popolazioni tibetane non sempre corrispondeva alle qualità di lama e abati dagli abiti pomposi, titolari di labrang – le proprietà dei monasteri – i cui amministratori o Geko erano spesso in guerra con altri per l’influenza sui villaggi e entrate più larghe. Lo stesso zio Khyentse e il suo precedessore dovettero subire campagne di discredito dei grandi monasteri e dei loro stessi Geko per la loro opposizione al circuito del dharma business e i lunghi periodi passati negli eremi a praticare.
Rimpoche tornò nel suo paese 34 anni fa con l’intento, realizzato, di porre in quell’anno le basi delle attività di A.S.I.A. ma capì che esistevano le condizioni per la nascita della comunità Dzogchen cinese, oggi parte integrante di quella internazionale. A diversi livelli dell’amministrazione pubblica da Pechino a Chengdu, da Qamdo a Derghe in molti vollero sostenere le sue idee per una integrazione tra due mondi apparentemente tanto separati come Tibet e Cina. Rimpoche rese chiaro a tutti che i due vicini, seppure divisi dalla politica avevano a lungo avuto intensi interscambi culturali e religiosi, fin da quando il buddhismo si diffuse dall’India anche in Cina attraverso i primi pellegrini. Ricordò che molti imperatori si convertirono al Vajrayana e – come avevano fatto i potenti khan mongoli – ricevettero numerosi insegnamenti spirituali da diversi Dalai lama.
Il maestro disse fin dal suo arrivo a Pechino che intendeva aprire scuole e creare servizi comunitari specialmente per i nomadi, ma anche avviare seminari per monaci di tradizioni tradizionalmente neglette. Sapeva che non sarebbe stato facile ma quel periodo storico era forse l’unica finestra aperta dentro la grande muraglia dell’ideologia cinese. Infatti dopo Tien an Mien la Cina tornò a chiudersi e trasformo’ radicalmente il panorama e lo stile di vita di gran parte della popolazione. È stato un merito di A.S.I.A. quello di poter concludere i suoi progetti evitando la sorte di altre onlus internazionali indipendenti costrette a lasciare il paese, senza abbandonare mai l’idea originaria di portare sostegno a comunità vittime “collaterali” di un progresso che stava stravolgendo – oltre all’ambiente sul tetto del modo – sistemi antichi ed efficienti di sussistenza delle tribù, specialmente nomadi.
 Rimpoche parlava spesso in viaggio dell’importanza di questi pastori erranti nella cultura tibetana (scrisse un libro interamente dedicato a loro) e della loro relazione con la natura primordiale. Di nomadi ne incontreremo a centinaia sotto le loro tende di stoffa usate durante gli spostamenti brevi, o di lana di yak delle residenze invernali. Il Maestro li intratteneva per ore raccontandogli storie dell’esotico occidente che incantavano grandi e bambini al fuoco delle stufe, e ascoltava i loro racconti chiedendo di spiegargli cos’era successo alle loro vite dopo l’arrivo dei cinesi. Seppe che gli esperimenti delle cooperative di nomadi erano falliti ma che tutti temevano qualche altra iniziativa per limitare la libertà da sempre goduta dalle famiglie di scegliere le pasture per gli animali. (Oggi purtroppo i nomadi vivono in gran parte dentro compound di stile cinese e si sono visti imporre una vita più sedentaria e controllata).
Rimpoche parlava spesso in viaggio dell’importanza di questi pastori erranti nella cultura tibetana (scrisse un libro interamente dedicato a loro) e della loro relazione con la natura primordiale. Di nomadi ne incontreremo a centinaia sotto le loro tende di stoffa usate durante gli spostamenti brevi, o di lana di yak delle residenze invernali. Il Maestro li intratteneva per ore raccontandogli storie dell’esotico occidente che incantavano grandi e bambini al fuoco delle stufe, e ascoltava i loro racconti chiedendo di spiegargli cos’era successo alle loro vite dopo l’arrivo dei cinesi. Seppe che gli esperimenti delle cooperative di nomadi erano falliti ma che tutti temevano qualche altra iniziativa per limitare la libertà da sempre goduta dalle famiglie di scegliere le pasture per gli animali. (Oggi purtroppo i nomadi vivono in gran parte dentro compound di stile cinese e si sono visti imporre una vita più sedentaria e controllata).
La natura del Tibet
Fu in due occasioni, rimaste impresse nella mia memoria, che Rinpoche spiegò il rapporto tra mistici tibetani e natura, in anni durante i quali le preoccupazioni ambientali non erano ancora il tema del giorno. Un mattino mentre attraversavamo un bosco del Tibet orientale, molto più verde di quello occidentale, disse che ogni albero era per lui un oggetto di contemplazione. Nei miei appunti annotai di avere avuto un flash, immaginai un mondo dove ciascuno viveva in simbiosi con il proprio albero come poteva accadere in una delle tante dimensioni di cui mi parlò il Maestro. Pensai anche al fatto che sotto un banyan si sarebbe illuminato il Buddha, e sotto gli stessi rami uscì dal grembo della madre.
A metà maggio la neve non era ancora sciolta sui prati delle alte quote che si riempivano di fiori gialli e rossi sotto cieli di un azzurro mai visto. Ci fermammo qualche chilometro prima del monastero dello zio abate Khyentse W dove scendemmo dall’auto per seguire a piedi una strada laterale sterrata e qui apparve l’incanto di un laghetto circondato di abeti e ginepro. Rinpoche fissò intensamente i colori e le forme incantevoli dello specchio d’acqua che sembrava un turchese trasparente incastonato tra la neve e il verde intenso degli alberi. Disse di esserci venuto con lo zio abate quando aveva 11 anni, e ne fu talmente incantato che voleva costruirci un monastero. “Da allora – mi disse – ogni volta che la mia mente è disturbata da elementi esterni e da problemi apparentemente irrisolvibili, torno sempre qui, in questo lago”.
Spiegoò che quando era piccolo aveva un’idea molto diversa delle priorità essendo stato educato a diventare un maestro e potenziale capo di qualche monastero. Ma l’importanza delle istituzioni religiose divenne relativamente secondaria per Rinpoche quando incontrò il suo Maestro di Dzogchen Changchub Dorje a Khamdogar del quale spero di poter parlare nella seconda parte di questo racconto.
Quella mattina sulle rive del lago della sua infanzia il maestro spiegò la sua nuova idea su come utilizzare quel luogo incantevole. “Se possibile vorrei costruire qui un luogo di pratica che possa essere anche utilizzato dalla nostra gente della comunità internazionale”, disse. Non so se quell’idea ha poi trovato applicazione, ma temo che l’irrigidimento politico e la politicizzazione delle autorità religiose possa avere reso difficile questa parte del programma di Rinpoche.
Per dare un’idea dei cambiamenti avvenuti al tempo del suo arrivo, il Maestro giunse a Pechino da Hong Kong quando mancavano 9 anni al ritorno dell’isola alla Cina, evento che secondo lui poteva cambiare gli assetti di potere anche a Pechino. C’era stata la perestroika con le prime riforme liberali russe e Deng Xiao Ping a Pechino apriva la Cina al mondo, ospitando perfino i primi inviati del “nemico” Dalai lama a Lhasa. Un anno dopo il viaggio del Maestro, la rivolta di Tien an Mien fu di fatto il tentativo di ridimensionare il potere della classe dirigente del nord, di lingua mandarina. Dal mondo degli uomini d’affari e politici del sud tradizionalmente più aperti proveniva un potente simpatizzante degli studenti in rivolta, il segretario generale del partito Zhao Zhiyang, poi allontanato.
Era facile capire come applicando la base dello Dzogchen il maestro agisse secondo le circostanze che imponevano il rispetto delle leggi ma anche delle abitudini dei paesi che incontravamo. Era esteriormente facile per lui, anche se a livello emotivo lo accompagnava un sentimento di enorme tristezza fin da quando per rivedere il suo Tibet aveva dovuto ottenere l’autorizzazione da genti straniere. Il Maestro ha autoliberato col tempo gli ostacoli di passioni profonde e dolorose, perfino il senso di colpa che mi disse di aver provato per aver messo in pericolo la sua famiglia in quanto “buddha vivente”, quindi nemico del popolo.
Qui vorrei anticipare un altro aspetto importante – di certo lo fu per me – di quel viaggio dell’88. Mentre salivamo in jeep gli altipiani oltre Ya’an per entrare in Tibet Rimpoche mi chiese che cosa pensassi di Sua Santità. Mi resi conto di non avere una risposta precisa, conoscendo poco gli stessi metodi della sua scuola Gelugpa. Risposi che lo conoscevo più come leader politico che religioso, e allora il maestro mi parlò di una storia che sarebbe diventata la mia ossessione negli anni a venire, anche se in quel momento non mi resi conto della sua importanza per il futuro stesso della cultura tibetana e del suo rappresentante più celebre, l’attuale XIV detentore del titolo di Oceano di saggezza. Spiegò che il movimento anti-settario Rimed nel quale si identificava, aveva fino agli anni ’70 una forte riserva verso una forma di culto delle “Guardie” o protettori alla quale era associato il leader tibetano. Prevedeva infatti la “presa del rifugio” in un essere considerato difensore della pura dottrina Gelugpa contro ogni altra “contaminazione”. Quando i berretti gialli erano al potere “coniavano anche le monete” mi spiegò un giorno il Maestro davanti a un grande monastero della scuola a Derghe, “e non intendevano cedere il potere del loro clero ad altre scuole”.
Solo più tardi seppi che al tempo della sua “iniziazione” al controverso “spirito” il Dalai lama era circondato di tutori e consiglieri che praticavano il culto di un essere gyalpo chiamato Shugden, anche se il protettore ufficiale di tutti i Dalai lama era Palden Lhamo. Di conseguenza “nessun religioso delle altre tre scuole – mi disse il Maestro – né altri praticanti dello Dzogchen come me avrebbero mai preso iniziazioni dal Dalai Lama”. La causa era proprio quel suo legame con uno “spirito nocivo”, come lo definirà anni dopo il Dalai Lama stesso. “Ma ora – aggiunse il Maestro – tutto è risolto. Sua Santità ha capito lo spirito divisivo di quella pratica e ha invitato tutti i tibetani a interromperla. Ora sono pronto a ricevere un’iniziazione da lui” (cosa che accadrà a Gratz anni dopo, ndr).
Il motivo di quel vecchio conflitto mi risultò sempre più chiaro quando lavorai con il sostegno del Maestro e dello stesso leader tibetano esule al libro sulle conseguenze di quella vicenda per gli eventi storici ancora in corso. La Cina troverà nei lama del culto dei fedeli alleati per la strategia di sostituire alla sua morte il Dalai Lama con un tulku educato dai suoi nemici interni e dai consiglieri del partito. Giunsero anche a finanziare la rumorosa campagna internazionale anti-Dalai Lama accusato da una “coalizione” pro-Shugden di “persecuzione religiosa”, con azioni pubbliche che ebbero vasta eco internazionale e poco effetto pratico.
Ma vorrei tornare ora alle tappe del viaggio da quando lasciammo la capitale cinese Pechino, dove il maestro alloggiava nella casa di Donatella Rossi in un compound per occidentali e io nelle stanze in affitto degli studenti nell’università di Beidà, dove di lì a poco si accenderà il primo focolaio delle rivolte di Tien An Mien che porrà fine all’era più liberale di Deng.
Atterrammo la sera del 2 maggio a Chengdu, capoluogo del Sichuan e ancora oggi porta d’ingresso turistica al Tibet, accolti da una piccola folla di parenti e tibetani avvisati del suo arrivo. Tra loro la sorella del Maestro Sonam Palmo, di poco più anziana e straordinariamente somigliante tranne le lunghe treccine coi turchesi e nastri colorati come un’indiana d’America.
Era giunta da Lhasa con la figlia adottiva Phuntsok, un medico oggi noto a molte persone della comunità e indossava un cappellino di lana marrone, una chupa abbondante e sproporzionata al caldo della pianura cinese dalle cui maniche uscivano i guanti aperti sulle dita che ruotavano lentamente e continuamente un mala. Rimpoche e il suo variopinto corteo – che non mancò di far colpo su un gruppo di turisti giapponesi – incuriosì anche i giovani cinesi alla reception del Minshan hotel, pure abituati alla presenza di tutte le etnie tibetane in città.
In parte il corteo si trasferì – scherzando sugli ascensori ancora inusuali in Tibet – nella stanza messa a disposizione del Maestro e del suo assistente dall’Istituto delle minoranze. Il direttore aveva spedito un’auto all’aeroporto ed era venuto a sincerarsi personalmente che il sapiente venuto dall’Ovest si trovasse a suo agio. Volle anche farci provare subito le specialità super piccanti del Sichuan anche se era già sera tarda. Rimpoche ricordò a cena il suo viaggio negli anni ’50 attraverso questa provincia e lo stato, quando i cinesi non avevano ancora raggiunto gli eccessi della rivoluzione culturale e il maestro accettò di viaggiare in varie città cinesi come rappresentante della gioventù comunista del Tibet. Ricordando quegli anni spiegò al direttore dell’Istituto che per lui è sempre stato importante conoscere come si forma la società di un paese per sapere qual è il modo migliore di comportarsi in ogni circostanza e con rispetto. “Quando giunsi in Italia negli anni ’60 – gli disse – dopo aver appreso le basi della lingua, frequentai sia le sezioni del partito comunista che i circoli parrocchiali cattolici per capire come pensava la gente”.
Al mattino successivo, dopo una brusca sveglia non richiesta del notiziario radio nazionale delle 06.00, Rimpoche mi spiegò che ben pochi degli interlocutori cinesi che avremmo incontrato sapevano distinguere tra religiosi clericali e maestri senza “chiesa” quali sono considerati i praticanti dello dzog chen. Chiesi al Maestro con quale spirito avrebbe attraversato un paese come il suo, dove – nonostante le aperture recenti – la politica del partito sembrava giocare un ruolo sempre più importante di quello della religione in ogni aspetto della società. Rispose che in ogni circostanza è sempre meglio riflettere sulla ragioni che dividono la società e non schierarsi mai completamente con una delle parti perché si può perdere la possibilità di agire per il vantaggio di entrambe. Spiegò che questo insegnamento più pratico che spirituale lo aveva appreso non da uno dei suoi maestri di dharma, né dagli zii abati yogi, ma da un fratello di suo padre che fu un importante uomo politico e vice presidente di una provincia. “Questo zio – raccontò Rinpoche – mi spiegò che autorità e potere gli venivano dalla sua capacità di esporre le critiche al sistema ma di saper trovare sempre una mediazione. Quando avevo 15 o 16 anni mi disse: “Tu ora sei giovane ma quando crescerai non stare mai completamente da una parte o dall’altra”.

Jamyang Chökyi Wangchug. Per gentile cortesia di Master Bi Song
Il maestro viaggiò nel suo Tibet costellato di ricordi della drammatica sorte di amici di gioventù, maestri, persone care, un padre e un fratello uccisi nei campi di lavoro cinesi, e il misterioso decesso dello zio Khyentse Wangchuk, abate del monastero e leader spirituale del villaggio di Galenteen dove passeremo molte settimane. Khyentse doveva essere linciato e fucilato pubblicamente insieme ad altri tre maestri suoi amici e grandi praticanti nel capoluogo Derghe in quanto “falsi Buddha viventi nemici del popolo” e dimostrare la loro vulnerabilità umana. Ma 3 giorni prima dell’esecuzione l’abate venne trovato senza vita nella posizione meditativa dalle guardie rosse della prigione dov’erano tutti rinchiusi. Non solo, in celle diverse e allo stesso tempo morirono gli altri lama.
Nella stessa prigione era costretta a lavori estenuanti la sorella anziana di Rimpoche Jamyang Chodron, una discepola di tutti e tre: il Khyetse, Shechen Rabjam e Drugpa Kuchen. Fu la sola a poterli incontrare, isolati com’erano ta loro, e fu lei a portare agli altri l’unico messaggio del Khyentse, una frase sul Grande simbolo che era stata concordata forse anticipando ciò che sarebbe loro successo, lo stesso trattamento umiliante subito da altri maestri, costretti a percosse, crudeli processi e perfino a farsi cavalcare da invasati con delle redini al collo, esecuzioni sommarie. Sono molti i dettagli delle crudeltà commesse dai cosiddetti burtsonpa (gli attivisti) come vedremo ancora, e li descrive il Maestro nella biografia de La Lampada trasmessa ad Enrico alla quale rimando per chi voglia saperne di più.
Centinaia di maestri e discepoli vennero torturati ferocemente davanti a folle eccitate dal sangue e dalla violenza sui “controrivoluzionari”, una “evidente manifestazione di gyalpo – mi disse il maestro – che si nutre della rabbia e delle provocazioni dell’uomo all’ordine della natura primordiale”. Il mondo seppe solo più tardi il clima di terrore che si era creato in ogni famiglia spesso divisa tra figli di opposte posizioni sull’indipendenza dalla Cina e la fedeltà alla religione degli avi.
Rinpoche stesso, nel Sikkim indiano dal ‘56 senza più collegamenti con il Tibet occupato, mi disse che fino al ’79 non riuscì in generale a sapere niente della sorte dei suoi parenti. Ma all’inizio degli anni ’70 “la notizia della morte di Khyentse Wangchuk – spiegò – mi giunse in modo del tutto inatteso. Un maestro a capo della scuola Sakyapa mi scrisse per dirmi che aveva avuto la visione dello zio reincarnato in mio figlio Yeshe, così venni a sapere che era morto”. Durante il soggiorno a Galenteen racconterà altri dettagli, tra i quali la morte innaturale di due degli accusatori di suo zio davanti al “tribunale del popolo”. Ma rimando ancora a La Lampada, e racconterò più avanti solo un aneddoto personale interessante che riguarda altre due figure di ex “rivoluzionarie” torturatrici ancora in vita.
Continua nel prossimo numero di The Mirror.
Questo post è disponibile anche in:
Inglese